AVVISO: Il seguente articolo contiene spoilers sulla trama di alcuni film del FEFF 25

L’unico film cinese della mainland presente nella selezione online, Homecoming (China 2022) di Rao Xiaozhi, conferma come stia diventando sempre più difficile, se non addirittura impossibile, superare lo scoglio della propaganda e della censura governativa per realizzare qualcosa di significativo e non ammantato di retorica o buoni sentimenti un po’ fatui e senza profondità. In questa opera, che se non altro ha il pregio di cercare di non demonizzare a tutti i costi chiunque non sia cinese, i protagonisti sono dei diplomatici rimasti bloccati con alcuni connazionali in un fittizio paese islamico piombato nel caos per via di un attacco terroristico. Nonostante alcune trovate tutto sommato apprezzabili ‒ fra tutte, la possibile amicizia fra il disilluso diplomatico cinese e il generale del paese ospitante, quasi a voler illudere spettator3 su un nuovo corso della politica cinese, basato sull’unione fra popoli invece che sul dimostrare a tutti i costi la propria superiorità al resto del mondo ‒ il film ripiomba inevitabilmente nel pantano dell’autoesaltazione nazionalistica, con tanto di paesaggio balneare idilliaco che dovrebbe fungere da simbolo del zhōngguόmèng 中国梦, la risposta cinese al sogno americano. Non manca una frecciatina alla questione taiwanese, buttata lì quasi per caso, come se dovesse passare inosservata (ma vi invito a farci invece caso, perché è un chiaro messaggio politico): di fronte alle perplessità mostrate dal protagonista, che medita se rimanere ancora in servizio all’estero o tornare in patria, un collega cerca di convincerlo dicendogli che ha tutto il diritto di rientrare in Cina e di far nominare al suo posto “un connazionale di Taiwan”. L’espressione, tutt’altro che innocua, è quasi una dichiarazione di guerra, e ribadisce la posizione del governo cinese riguardo la delicatissima questione del (mancato) riconoscimento politico ediplomatico di Taiwan in quanto paese indipendentedalla Repubblica Popolare Cinese. Benché sia innegabile constatare come, oltre a non far parte dell’ONU e ad essere riconosciuta da pochissimi paesial mondo come nazione indipendente,la Repubblica di Cina (anche dettaTaiwan)incarni una realtà politica molto ambigua, l’affermazione che un diplomatico della Cina continentale possa essere sostituito da uno di Taiwan sottintende non soltanto la piena aderenza alla teoria “Un paese, due sistemi”, enunciata da Deng Xiaopingnel 1979 e mirata all’unificazione “pacifica” fra le due realtà, ma anche alla visione ben più aggressiva e repressiva (in stile Hong Kong) di Xi Jinping. Apparentemente innocua, quella battuta sta lì a indicare come la Cina voglia occupare “ogni centimetro possibile” di territorio occupato da persone di etnia cinese, senza necessariamente chiedere l’opinione degli abitanti del luogo in questione perché in fondo si tratta di un territorio “concesso temporaneamente” agli avversari politici, e che deve quindi essere restituito senza condizioni.

A proposito di realtà temporanee, l’ex colonia britannica di Hong Kong, tornata alla mainland nel 1997 e teatro di innumerevoli trasformazioni nel corso del ventesimo secolo, da deserto culturale e trionfo del kitsch architettonico a non lieu per eccellenza, e soprattutto corpo-proiettile di un cinema saettante in grado di stupire il mondo intero con il suo sguardo déjà disparu (secondo la celebre espressione di Akbar Abbas), all’indomani della brutale repressione delle proteste 2019-2020 da parte delle autorità cinesi si ritrova a dover fare i conti con le macerie della propria identità. Paradossalmente, laddove la new wave degli anni 1979-1997 celebrava tutte le contraddizioni di un non-luogo “a scadenza”, fatto di immagini, sentimenti e persone sfuggenti senza storia e al di fuori del tempo in uno spazio strabordante e senza confini, il cinema hongkonghese di oggi sembra voler tracciare il percorso di un passato strappato via troppo presto dalle maglie della memoria, complice il pugno impietoso della storia. In altre parole, il lungo e doloroso percorso dal ritorno alla Cina alla repressione totale della libertà ha costretto cineast3 dell’isola a scoprire un senso di nostalgia per qualcosa di irrimediabilmente perduto e che si è andato coagulando negli ultimi anni in un’esplorazione di ciò che rende Hong Kong distintamente hongkonghese e incontaminato (o semplicemente diverso) dal resto della Cina. Il cinema degli ultimi tempi cerca dunque di farsi a modo suo depositario della memoria collettiva, anche se con una vena di amarezza perché rintraccia tradizioni ormai perdute o in via di estinzione. A light never goes out (Hong Kong, 2022) di Anastasia Tsang, nello specifico, celebra una delle arti che hanno reso Hong Kong famosa in tutto il mondo: le insegne al neon, create a mano dai maestri soffiatori ma da anni diventare oggetto di una guerra da parte delle autorità perché ritenute dannose alla salute e all’ambiente. Unendo la memoria collettiva di una nobile tradizione cittadina (“Un’insegna al neon è essenzialmente fare calligrafia con la luce”, viene detto nel film) al ricordo personale del marito defunto della protagonista, Anastasia Tsang ci regala un’opera dolce-amara che cerca di restituire dignità e spessore a una delle caratteristiche fondanti della città nel momento stesso in cui essa va scomparendo – a suo modo creando un’ennesima variante del déjà disparu cercando però di trattenerne la scia, invece di lasciarla bruciare e poi svanire.

Parlando di tradizioni, Gaga (Taiwan, 2022, in originale Hayong jia 哈勇家, ossia “La famiglia di Hayong”) di Laha Mebow, descrive invece le vicissitudini di una famiglia di etnia tayal in un villaggio taiwanese. In particolare, la morte del nonno Hayong porta la sua famiglia ad un progressivo allontanamento dalle tradizioni, soprattutto per via della decisione del figlio Pasang (Wilang Lalin) di candidarsi a sindaco, con conseguente indebitamento per sostenere le spese della campagna elettorale nel miraggio di una vita migliore. Nel frattempo, Ali (Ali Batu), la nipote di Hayong, scopre di essere incinta, cosa che mette in subbuglio l’intera famiglia. La visita del suo compagno australiano (la ragazza era infatti appena tornata da un periodo di studio in Australia) diventa l’occasione per celebrare le “nozze” davanti a tutta la comunità, non solo come buon auspicio per la coppia ma anche per ribadire a tutti che votare per Pasang garantirà gioia e prosperità. Utilizzando attor3 per lo più non professionist3 e di etnia tayal (e tayal lei stessa), Laha Mebow crea un’opera sul come la sete di progresso e la modernità riescano ad insinuarsi fra le pieghe della tradizione autoctona, cercando però di non scivolare mai nella tragedia. Premiato per il miglior film e la migliore sceneggiatura al Golden Horse Film Festival, il principale festival cinematografico taiwainese, Gaga è sicuramente apprezzabile soprattutto per lo sguardo semplice ma efficace sulla corruzione di alcuni e l’ingenuità di altri e per il suo descrivere senza troppi fronzoli le usanze di una minoranza etnica che continueranno nonostante l’ostinazione ad agognare falsi obiettivi rischi di rovinare per sempre la propria identità e i rapporti con il resto della famiglia.

Meno convincente ma a suo modo interessante, il film a episodi She is me, I am her (Giappone, 2022) di Nakamura Mayu intreccia storie di quattro donne diverse (accomunate dalla stessa attrice, Nahana) che ci aiutano a riflettere sulla solitudine femminile e sull’incomunicabilità forzata causata dalla pandemia. Se Among Four of Us ricorda per stile e struttura dei dialoghi Wheel of fortune and fantasy di Ryusuke Hamaguchi, senza però condividerne la freschezza, Someone to watch over me crea un’improbabile storia d’amore da una situazione di stalking, il che conferma come culturalmente in Giappone il confine fra molestie da una parte e comportamenti codificabili come corteggiamento, in una parola la dicotomia fra coercion e consent, sia quanto meno problematico. Il film non ci spiega perché mai una donna dovrebbe accettare le attenzioni di uno che l’ha spiata, seguita e fotografata ossessivamente come qualcosa di “sano” e legittimo, invece di vederlo come una vera e propria forma di violenza persecutoria, anzi, sembra giustificare le azioni criminali dell’uomo ammantandole di un presunto sentimento romantico, in ultima analisi insegnando alle donne a dire sì sempre e comunque, perché vuoi mettere lo stare con qualcuno invece della solitudine… Tralasciando Deceive me sweetly, la cui trama è piuttosto confusa e ha come unico scopo quello di confermare la bravura dell’attrice nel suo indossare le vesti di un nuovo personaggio, personalmente ritengo il film degno di nota soprattutto per il terzo episodio, Ms Ghost, vera e propria denuncia del maschilismo dell’industria cinematografica giapponese, che costringe le donne a prostituirsi per la fama (a volte in senso letterale, girando film porno per sopravvivere), salvo poi buttarle via quando non servono più. L’incontro fra due attrici, una giovane e ancora a un passo dalla rinuncia, una ormai appassita e costretta a vivere per strada perché senza più un ingaggio né illusioni, è il ritratto impietoso di una società per soli uomini, dove le donne possono solo fungere da serve o al massimo oggetti di contorno, per poi trasformarsi in fantasmi che nessuno più vede. Nahana ci regala qui una recitazione disincantata e quasi sull’orlo del disastro, ma è la sua controparte “spettrale” Asada Miyoko a brillare nell’episodio, gettando a terra la maschera del successo e rivelandone il guscio vuoto che constringe le donne a incarnare figure di passaggio in un mondo maschile. Un’opera di certo contraddittoria nel suo messaggio complessivo, soprattutto per quel che riguarda il ruolo delle donne nella società giapponese e il loro peso nella cultura del paese.

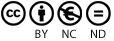





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
