“Il castello è in rovina, rimane solo l’erba alta”, recita una delle canzoni scelte per allietare l’ennesimo banchetto organizzato dal dittatore Park Chung-hee (Lee Sung-min) nella Casa Blu, la residenza presidenziale. Affiancato da alcune ragazze e dai suoi più stretti collaboratori fra i quali Kim Gyo-pyong (Lee Byung-hun), direttore della agenzia di spionaggio anticomunista sudcoreana, la KCIA, e il capo della sicurezza Kwak San-cheon (Lee He-joon), il tiranno non sa ancora che il suo castello apparentemente inespugnabile è davvero in rovina e che è in procinto di andare incontro alla morte per mano di uno dei presenti. Quello che importa è continuare ad eliminare ogni possibile avversità nel momento stesso in cui si verifica, mettendo i suoi uomini gli uni contro gli altri in modo che gli eventi degli ultimi quaranta giorni rimangano solo un vago ricordo, anche se sarà un ricordo destinato ad affievolirsi per sempre, come il suo respiro una volta che lo sparo lo travolgerà.
Salito al potere nel 1963 dopo aver guidato il colpo di stato del 1961 volto a rovesciare la Seconda Repubblica, Park Chung-hee ha rapidamente stabilito una forma di “democrazia guidata”, reprimendo la libertà di stampa e di espressione, controllando le università e il sistema giudiziario e organizzando una rete di terrore e repressione messa in atto proprio attraverso la creazione della KCIA grazie all’aiuto degli ex commilitoni con cui ha realizzato il colpo di stato. Successivamente, ha instituito la legge marziale, instaurando un regime sempre più repressivo contro le voci di dissenso e concedendo a se stesso e alla KCIA poteri pressoché illimitati. Tutto sembrava andare per il meglio all’inizio; il regime aveva anche l’appoggio degli americani, che chiudevano volentieri un occhio di fronte al fervore anticomunista dimostrato dal presidente e dai suoi uomini. Imbaldanzito dalla propria onnipotenza, giunto ormai al diciottesimo anno di potere Park Chung-hee ha deciso di far espellere il leader dell’opposizione Kim Young Sam dall’Assemblea Nazionale (il Parlamento sudcoreano), ma la sua decisione ha scatenato una serie di rivolte in tutto il paese. Certo, questi sono solo graffi sull’armatura che si porta dentro, rimasta inalterata nel corso degli anni grazie a una fiducia incrollabile in se stesso e nel proprio sistema. L’unica vera scalfittura che sembra incrinare le sue certezze fino a squarciarle è il recente tradimento di uno dei suoi fedelissimi, l’ex direttore della KCIA Park Yong-gak (Kwak Do-won).
A quaranta giorni da quel banchetto per lui fatale, Park Chung-hee si ritrova con uno dei sodali di un tempo in fuga negli Stati Uniti, dove dopo aver smascherato le nefandezze del regime all’FBI intende non solo chiedere asilo politico ma anche rendere pubblico un virulento memoriale scritto di suo pugno in cui accusa apertamente l’ex amico dittatore di essere “il traditore della rivoluzione”, di aver trasformato la democrazia sudcoreana in una tragedia e la bandiera “in una striscia di sangue”.

Di fronte a una minaccia così forte, già definita dai media statunitensi come il “Koreagate” e che rischia di attrarre le attenzioni invadenti degli americani su questioni interne al paese da lui costruito e che non devono riguardare nessun altro oltre a lui, Park Chung-hee non può che ordinare a Kim Gyo-pyong di recuperare il memoriale e convincere il traditore a tornare sui suoi passi. Fedele alla memoria di quel che è stato, Gyo-pyong non esita a rimanere a fianco del presidente, la cui parola per cui non deve in alcun modo essere messa in discussione. Quello che però dovrebbe essere un semplice incarico mirato a convincere un amico di vecchia data a non rinnegare il passato, ben presto si trasforma in un triplo gioco spionistico dove Gyo-pyong si rende progressivamente conto di non avere più il controllo della situazione, e soprattutto che il suo ruolo come leader della KCIA e uomo di fiducia di Park Chung-hee in realtà è ben più precario di quanto pensasse. Forse, per recuperarlo e riprendere terreno contro l’evidente ascesa di Kwak deve fare molto più che convincere, soprattutto quando il memoriale, inevitabilmente, salta fuori lo stesso nonostante il suo intervento, o forse proprio a causa di esso. Il presidente si fiderà ancora di lui? E lui, saprà fidarsi ancora del presidente?

Scritto e diretto da Woo Min-ho e basato su un romanzo dal titolo omonimo, The Man Standing Next ricostruisce i quaranta giorni che portarono alla pianificazione dell’assassinio del dittatore Park Chung-hee con il ritmo serrato di un ottimo film di spionaggio, dove nulla è come sembra e discernere la verità dal sospetto è ormai impossibile a causa di un’opacità di sguardo che da tempo affligge tutti gli astanti, corrotti dal potere e da un’etica costruita sui mattoni della tortura e dell’omicidio. Sorretto principalmente dall’ottima recitazione di Lee Byun-hun (forse non è casuale che a introdurre il film al pubblico del FEFF 22 fosse proprio lui invece del regista), The Man Standing Next riesce in realtà anche a delineare benissimo l’agghiacciante e distorta visione del potere di un dittatore e la vana ricerca di una vaga forma di giustizia tardiva, e anch’essa distorta, da parte di chi crede ancora di potersi arrogare il diritto di salvare un paese malato, solo per venirne travolto a sua volta. Le immagini di repertorio che concludono il film con le dichiarazioni ufficiali dell’assassino e di colui che, approfittando della situazione precaria, prese il potere subito dopo (instaurando una nuova dittatura), finiscono per amplificare quel senso di stanca e allucinata amarezza con cui il protagonista Gyo-pyong si ritrova a lottare, rimanendone condizionato per sempre. Un ennesimo esempio di come i registi sudcoreani sappiano trarre dei blockbuster di ottima fattura dalla storia recente del paese, una storia sanguinosa con cui, a differenza di altri paesi orientali, la Corea del Sud sembra non solo voler fare i conti, ma tranne insegnamento per il futuro rendendola oggetto di intelligente intrattenimento, regalandoci delle opere che non hanno nulla da invidiare alle spy story americane e, anzi, spesso le superano in bellezza, oltre ché rivelarsi utili per farci conoscere eventi storici di cui, nella nostra presunzione euro/americo-centrica, non sappiamo assolutamente nulla perché da noi ritenuti “secondari” o “periferici” rispetto a un presunto centro di cui ci autoproclamiamocustodi esclusivi (ed escludenti).



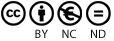





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
