AVVERTENZA: La seguente recensione contiene alcuni spoiler sulla trama e sul finale di Letter to an Angel di Garin Nugroho.
Benché fuori concorso essendo un film restaurato, Letter to an Angel di Garin Nugroho è stato uno dei momenti più memorabili del FEFF 26, di gran lunga preferibile (almeno per me) a diverse opere presenti nella selezione ufficiale della competition. Ambientato nell’isola indonesiana di Sumbain un villaggio non meglio identificato permeato dalla cultura animista e dauna vita sociale scandita da rituali e sacrifici di animali (alle cui riprese molti abitanti locali hanno partecipato attivamente, lasciandosi filmare dal regista), il film narra la storia di Lewa (Windi Prasetyo Budi Utomo), un bambino progressivamente lasciato solo dalla società di adulti che lo circorda man mano che la storia progredisce.
Fin dall’inizio, la sua vicenda personale è segnata dal lutto e dalla perdita: la madre è morta in un “incidente stradale”, e il padre si barcamena come può lavorando il proprio appezzamento di terra. Gli unici amici che Lewa ha sono il mite Malaria Tua (Fuad Idris) –emarginato da tutti perché affetto da epilessia– la maestra del villaggio (Viva Westi Datuk)e la fiera Berlian Merah (Nurul Arifin), anche lei dedita al lavoro dei campi come il padre del bambino. Questa piccola famiglia allargatarappresenta uno spiraglio di luce in unmondo che ben presto mostrerà tutta la propria brutalità più cruda e più nera, rendendo l’esistenza di Lewa impossibile in quanto simbolo di qualcosa di incomprensibile – l’infanzia stessa – chenon ha alcuna ragione né alcun diritto di esistere, nemmeno quale ingenuo residuo di un’età perduta, in un universo edificato sulla violenza e la sopraffazione di chi resta e obbedisce piegandosi al potere, e la soppressionedi chi invece lo rifiuta.
A incarnare il mondo adulto con tutte le sue ingiuste asimmetrie e le sue innumerevoli forme di dominio, c’è la figura diKuda Liar (Adi Kurdi), vero e proprio boss malavitoso che tiene in scacco l’intera comunità, sostituendosi indisturbato sia al capovillaggio (che vediamo solo una volta di sfuggita) che alla polizia e alla legge (che compaiono all’improvviso nella parte finale del film, vera e propria celebrazione del dominio imperialista del più forte sul più debole, di cui parleremo più avanti). Significativamente, Kuda Liar entra in scena la prima volta come una specie di divo più che come un criminale: il suo atteggiarsi a Elvis, con tanto di ciuffo che cade morbido davanti agli occhi a bordo di un furgoncino a tema, serve a esaltarne lo status da intoccabile. Come una rock star, il boss mafioso locale si presenta come immortale e invincibile, e anche se il desolato contesto in cui si trova ad esercitare il proprio dominio finisce per evidenziarne la prosopopea e l’esagerazione grottesca, ciò che a un primo sguardo potrebbe apparire come ridicolo in realtà assume presto il valore di una minaccia reale e orrorifica, ingombrante tanto quanto l’aura volgare che ne accompagna i movimenti e le parole.
Una prima minaccia giunge ai danni di Berlian Merah, che Kuda Liar mira ad assoggettare e a trasformare in sua proprietà personale al pari di una mucca: ed è infatti attraverso il dono di questo animale, mandato come compenso per l’assassinio del marito, pugnalato “misteriosamente” alla schiena mentre lavorava i campi, che il boss mira ad appropriarsi della donna quale merce. La seconda minaccia va invece a toccare direttamente il padre di Lewa, proprietario di un terreno che fa gola al boss e alla sua smania di possesso: dopo averlo minacciato, Kuda Liar lofa uccidere dai suoi emissari, ai quali poi ordina di depositare il cadavere a terra fingendo di averlo ritrovato morto in fondo a un canyon – questa la versione ufficiale che raggiungerà Lewa quando vedrà gli uomini lasciare il corpo. La morte dei due capifamiglia è seguita dai rispettivi funerali, di cui il regista filma tutte le fasi, compreso il sacrificio di animali e il successivo rito di purificazione, per restituirci i ritmi di una comunità arcaica le cui usanze appaiono altrettanto brutali delle azioni ordinate dal boss mafioso, seppur codificate all’interno di un sistema sociale e rituale ben definito.
Nonostante il cappio dell’ingiustizia si stringa sempre più attorno al suo collo, restringendo la cerchia di persone non ostili con cui rapportarsi serenamente, Lewa ha comunque la vitalità spontanea tipica di un bambino della sua età: a differenza di quasi tutti gli altri personaggi – adulti, non a caso – la sua visuale sul mondo non è corrotta da pregiudizi né imbrigliata da regole o da ambizioni precise che ne incanalino il comportamento o le reazioni. Tutto per lui ha il sapore della scoperta, e il suo sguardo sulle cose è caratterizzato dalla genuinità di chi, non avendo punti di riferimento precisi, cerca di interpretare il mondo accogliendone gli stimoli, anche per dare un senso alla perdita che si fa sempre più drammatica e lacerante dentro e fuori di sé.
Questi due aspetti – la curiosità genuina e la perdita lacerante – trovano i loro rispettivi simboli in due oggetti che assumono un valore importante nelle giornate di Lewa: una macchina Polaroid, ottenuta da una modella grazie a un baratto (il bambino le dona in cambio una camicia), e un autobus ormai ridotto a uno scheletro pieno di paglia ed erbacce, abbandonato nel punto dove dovrebbe essere accaduto l’incidente della madre (anche lei probabilmente uccisa dagli uomini di Kuda Liar). Con la prima, Lewa scatterà alcune foto che restituiscano valore alla sua storia, ad esempio dando un volto più autentico alla madre e al padre rispetto ai disegni trovati sul libro di scuola, o che semplicemente registrino l’importanza di un incontro fugace, come accadrà quando si inoltrerà nel territorio di un villaggio rivale imbattendosi in una bambina sua coetanea. Nel secondo –presto sostituito con il rottame di un aereo dove giocare insieme a Malaria Tua –il bambino troverà una casa improvvisata, dopo che Kuda Liar gli avrà tolto tutto. Tali oggetti, e i gesti ad essi associati, si configurano come possibili forme di resistenza alla sopraffazione circostante, salvodiventare irrisori nel senso letterale del termine: gli adulti vedono infatti nel comportamento di Lewa qualcosa di ridicolo da ricoprire di scherno, o al limite qualcosa di ingenuo che suscita bonarietà, come la decisione di scrivere lettere a un angelo (dietro suggerimento della maestra, che diventa così complice di un’illusione), per “cercare la verità” sui genitori.

Ma presto i gesti di Lewa assumono un valore ulteriore, un interrogarsi sull’ingiustizia delle cose, e come tali cominciano ad attirare l’attenzione degli adulti, che se ne sentono di colpo minacciati: quando il bambino sottrae il cadavere del padre dal luogo di sepoltura per scattarne una foto realistica e dimostrare così quale sia il suo vero volto, rispetto al ritratto ideale di “padre” raffigurato nell’abbecedario di scuola, il villaggio insorge e tutti cominciano a definire Lewa “cattivo”. I suo gesti risultano di colpo inaccettabili e alieni, perché estranei alla logica degli adulti: quel suo innocente interrogarsi sul mondo e sulle sue assurde divisioni, che sottraggono le persone care e lo spazio vitale attorno a sé, viene bollato come sacrilego ed è dunque condannabile. Quello che guardiamo è via via un universo alla rovescia, dove la semplice curiosità di un bambino, il suo aprirsi alle cose, il suo lo stupore per la realtà, vengono perseguitati e via via negati. La sottrazione del cadavere del padre al tumulo della sepoltura rappresenta ovviamente uno rifiuto inconscio della logica dell’omertà: tutto il villaggio sa quanto è accaduto e sta coprendo Kuda Liar, e di conseguenza non può codificare il gesto di Lewa come forma di protesta sociale e perfino politica, ma soltanto respingerlo come qualcosa di “cattivo”.
La parabola discendente di Lewa prosegue con un altro incidente, che da iniziale outcast e poi sacrilego profanatore di tombe lo trasforma in autore di un gesto giudicato come “osceno”: dopo aver fotografato alcune donne mentre allattavano i neonati, ricevendo per questo in cambio alcune bastonate dagli uomini del villaggio, il bambino si ritrova a girovagare per i campi finendo in un altro villaggio, finché una bambina semi-svestita non gli appare davanti. Naturalmente incuriosito, Lewa le scatta delle foto e poi gliele regala. Ma il padre della bambina, e tutti gli uomini dell’altro villaggio, vedono in quelle istantanee polaroid una forma di violazione della purezza della piccola, e di conseguenza una minaccia all’onore e al buon nome di tutto il villaggio. L’ordine delle cose deve essere ristabilito, e da semplice afflato di conoscenza reciproca, il gesto di Lewa viene bollato come aggressione sessuale, qualcosa di bestiale e proibito non tanto perché la bambina non è consenziente (non sarebbe certo questa la motivazione, in un universo dove le donne non contano nulla e funzionano solo come merce di scambio o animali da domare e possedere) ma perché né suo padre né gli altri uomini del villaggio sono stati consultati affinché l’incontro fra i due bambini potesse avere luogo. Scoppia così una guerra, ma alla richiesta di Kuda Liar di immolare Lewa come pegno del disonore, il capo villaggio rifiuta.
Infine, da outcast a profanatore di rituali e di reputazioni altrui, Lewa finisce per essere dichiarato assassino, e dunque pericolo per la società tutta: in una colluttazione che rimarrà poco chiara fino alla fine, e a cui partecipa anche Berlian, Kuda Liar viene colpito a morte da una freccia. All’improvviso, la “giustizia” che fino a quel momento era risultata assente, fa il proprio ingresso nella storia: l’azione si trasferisce in tribunale, dove l’accusa non solo fabbrica prove assurde fra i quali fotografie di Berlian a seno scoperto per dimostrare un presunto istinto bestiale sia nella donna che nel bambino, ma addirittura lo fa assumendo il volto di una donna, cosa che in un mondo maschilista come quello descritto da Nugroho è non solo significativo, ma spia di un totale spregio del diritto fondamentale all’autodeterminazione e all’affrancamento dal sistema del potereda parte di chi – come appunto le donne e i bambini, da sempre storicamente assoggettatəall’uomo in quanto marito, padre, capo villaggio e così via fino alla punta della piramide sociale – quel potere lo subisce, tanto che la donna in questione appare come perfetta emanazione del potere, riproducendone in quanto avvocata dell’accusa il linguaggio e non contestandone affatto la struttura, anzi (non è un caso che sia lo stupro ai danni della maestra che quello ai danni di Berlian non siano mai oggetto di nessuna indagine).
Specchio di una società distorta che non è più in grado di vedere la verità per quel che è, l’accusa e con lei il giudice dichiarano Lewa colpevole riducendolo alla stregua di un indemoniato, un’anomalia che va rimossa dalla società perché nociva e pericolosa. Il boss mafioso e la rape culture da esso incarnato non vengono invece mai messi in discussione, e si intuisce che una volta finito il processo qualcun altro prenderà il posto di Kuda Liar, e tutto tornerà come prima. Per ristabilire lo status quo, il bambino, con la sua curiosità e il suo voler indagare il senso delle cose, deve dunque essere cancellato: non a caso, la Polaroid gli verrà sottratta, e le uniche forme di consolazione che rimarranno nel luogo dove la Legge rinchiude Lewa saranno la radio, un quaderno e penne per scrivere, e le visite di Berlian, anche lei sconfitta anche se unica sopravvissuta a una tragedia che ha visto soccombere via via tutte le persone che le erano attorno.
Quello di Berlian è un personaggio tenace ma in’ultima analisi piuttosto ambiguo: in un universo che non ammette onestà e innocenza, Berlian si adatta per non soccombere, e ci riesce nonostante tutto. Nel tratteggiare la sua storia e quella parallela della maestra, il regista (che è anche in parte autore della sceneggiatura) accosta volutamente due modi diversi di essere donne all’interno di un sistema che le vuole assoggettate come serve, vittime di violenza o merce di scambio. Da una parte, c’è la maestra, che se nella prima parte del film ha il compito di rischiarare il cammino di Lewa (e il proprio) con l’intelligenza di chi ha studiato, costruendosi una cultura basata sul raziocinio, il rispetto, l’onestà e una certa dose di fiducia nel prossimo (che per molti potrebbe apparire come innocenza sulle cose del mondo, ingenuità o cecità rispetto a quello che le succede attorno), nella seconda parte viene travolta da un violento stupro che ne spezza la volontà arrivando a cancellarla come persona: ridotta in lacrime, fuggirà dal villaggio (e la scuola sarà costretta a chiudere perché non nessuno oserà venire a sostituirla, condannando così Lewa e altri/e scolari e scolare all’ignoranza) e riapparirà soltanto fugacemente in tribunale, incapace di parlare e di controllare le proprie emozioni. Il raziocinio, la cultura, il rispetto, sembra dirci il regista, sono tutte cose inutili di fronte alla crudezza prorompente del potere: sordo a ogni rimostranza e a ogni tentativo di affrontare la vita con calma, contemplazione ogiudizio, il potere può solo calpestare con sadismo compiaciuto e noncuranza chi non sa accettare le sue leggi. D’altra parte, e anche questa sembra una scelta affatto casuale, la maestra rimane fino alla fine priva di un nome, a ribadire che il suo voler dare un senso ulteriore alle cose attraverso la cultura è fuori posto, non richiesto, inopportuno, e come tale bisogna eliminarne ogni traccia eogni slancio vitale, per riportare le cose al loro “ordine”, ossia alla barbarie della violenza.
Dall’altra parte, troviamo invece Berlian: lungi dal condividere la visione “innocente” e razionale del mondo incarnata dalla maestra, la contadina conosce bene il linguaggio brutale usato da Kuda Liar, accettando implicitamente la struttura gerarchica a cui esso rimanda. Perdere un marito per assassinio sembra lasciarla indifferente, così come priva di emozione appare la sua decisione di diventare la nuova moglie del boss. La sua è la scelta di mera sopravvivenza e opportunismo: non potendo contestare il volere del potente, una donna può solo usarlo a proprio vantaggio per non soccombere. Anche se, ovviamente, essendo la società in cui Berlian vive una società patriarcale, quel presunto vantaggio si rivelerà sempre esiguo e finanche illusorio: anche lei sarà infatti vittima di stupro, e se quel gesto di trafiggere Kuda Liar con una freccia non appare mai chiaramente codificato come suo, è perché le regole del patriarcato non sono le donne a farle ma gli uomini, e l’unico modo per vincere sarebbe o sottrarsi alla logica della barbarie, come cerca di fare la maestra – finendo per esserne sopraffatta – oppure sostituirsi al potere, cosa che in un universo del genere è esclusa a priori, altrimenti la storia prenderebbe tutt’altra direzione.
Un film straordinario e una vera e propria perla di riscoprire, Letter to an Angel si fa apprezzare sia per l’alternanza di immagini poetiche e brutali che per il suo sapiente tessere un mondo alla rovescia dove il potere soffoca ogni voce dissonante, travolgendone il senso e finendo per manipolare la realtà a proprio piacimento – un po’ come avviene a tutte le latitudini e in ogni epoca storica. Ed è proprio questo suo essere una denuncia contro l’eterna soppressione dell’Altro da parte del sistema, che non ammette divergenze dal suo discorso unico fagocitante, a rendere il film di Nugroho una parabola universale.


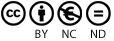





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
