Una delle opere più interessanti presentate al FEFF 26 di Udine, Voice di Mishima Yukiko narra tre storie (più una coda finale che chiude il cerchio) accomunate dal rifiuto di subire passivamente gli effetti di una violenza, opponendole la propria voce (da cui il titolo) per non lasciarsene travolgere.
Nel primo capitolo, ambientato sul lago Toya, nell’Isola di Nagajima, Maki (Carrousel Maki), vive isolata dal mondo dedicando le proprie giornate alla composizione di poesie e a onorare il ricordo della figlia Reiko, violentata e morta (forse suicida) quarantasette anni prima. Il dolore della perdita è ancora vivo nella mente di Maki, e forse è ancora più forte del dolore che la figlia ancora in vita, Masako (Kataoka Reiko), le causa ostinandosi a chiamarla “papà” e dunque rifiutando la sua identità di donna transgender. In procinto di rivedere Masako con la sua famiglia in occasione del capodanno, Maki prepara piatti elaborati come gesto di bellezza e dono disinteressato da donare ai suoi ospiti, anche se Masako non mancherà di ferirla con nuovi commenti transfobici, forse perché inconsciamente sente che la morte di Reiko le ha allontanate per sempre (e infatti dichiarerà di non tornare più sul lago in futuro). Rimasta sola, Maki compone un nuovo haiku: “Ogni suono che sento è trasparente/cerchi concentrici perfetti./ Cade la neve”. Sospesa nella solitudine del lago, cristallizzata in quell’unico, tragico istante in cui la polizia le comunicò la notizia della morte di Reiko, porterà la sua vita avanti con fierezza, cercando di dare senso ai ricordi.
Nel secondo capitolo, l’azione si sposta sull’isola di Hachijojima. Qui un tempo venivano mandati in confino i criminali violenti, ed è proprio uno di loro, Reita (che significativamente rimarrà una presenza-assenza fino alla fine, infatti non lo vedremo mai apparire sullo schermo) a ricevere l’amore di Umi (Matsumoto Kiyo): incinta e fermamente decisa a sposare colui che ama nonostante quel passato ingombrante e agghiacciante che gli ha segnato l’adolescenza, Umi dichiara le proprie intenzioni al padre Makoto (Aikawa Sho), che esprime forti perplessità al riguardo. Temendo per l’incolumità della figlia, si reca insieme a un amico all’arrivo dei traghetti, meditando di aggredire Reita. Quale sia l’esatta pena che l’uomo abbia scontato nel carcere minorile dell’isola tanti anni prima non ci dato di sapere: piuttosto che raccontare la violenza, in questo segmento la regista preferisce spostare lo sguardo altrove. Umi e Makoto devono anche loro fare i conti con il vuoto di una perdita, essendo la madre/moglie Seiko morta dieci anni prima: il gesto di Umi si configura dunque come possibilità di ricominciare, facendo tesoro dell’assenza e tramutandola in volontà di vivere nonostante tutto.

Nel terzo capitolo, ambientato ad Osaka e girato in un elegante bianco e nero, Reiko (Maeda Atsuko) – che nonostante il nome non ha nulla a che vedere con la figlia defunta del primo episodio – ha appena partecipato al funerale del suo ex fidanzato, e camminando per strada viene avvicinata da un gigolò: presentandosi come Totò Moretti (Bando Ryota), le propone di “noleggiarlo” per un giorno. Più che di sesso, in realtà, Reiko ha bisogno di raccontare se stessa, e di rielaborare una violenza sessuale subita all’età di sei anni, così gli propone di andare nel luogo del suo trauma personale, uno scorcio di strada invaso ora come allora da bocche di leone. “Tutti quei fiori rosa mi sembravano delle labbra”, dice Reiko ricordando al alta voce, e l’insieme di petali ci abbacinano gli occhi come tante creature oscene e carnivore. Segue un lungo primo piano di Reiko, che giustamente viene lasciata sola nello sfogo del suo dolore che è innanzitutto voce e in quanto tale deve potersi innalzare al cielo per potersi sciogliere del tutto e liberare il corpo e la mente. È proprio in questa sequenza che, a mio avviso, diventa evidente che a girare il film sia una donna: in rispetto del trauma di cui diventa ascoltatore, Totò Moretti decide di tenersi in disparte, e non lo vediamo più comparire a lungo sullo schermo, come a dire che il dramma subito da Reiko, e il suo percorso di autoaffermazione, non può essere condiviso né tanto meno può prevedere la presenza intrusiva del male gaze. Quella compiuta dalla regista è una chiara scelta politica, e tutta la sequenza vale da sola la visione del film: l’intensità della recitazione di Maeda Atsuko e la forza disarmante dell’elaborazione del trauma di Reiko ci descrive un voler rivendicare per sé non più il ruolo di vittima o sopravvissuta, ma quello di donna che con fierezza decide del proprio destino senza lasciarsi sopraffare da quel singolo e sporco gesto di reificazione col quale certi uomini intendono affermare il proprio dominio perché non sanno concepire un mondo senza dominate né dominatori. Nel descrivere un percorso di rivalsa catartica e di autoaffermazione che per certi versi rieccheggia il potente di The Nightingale di Jennifer Kent, Mishima Yukiko ci regala delle riflessioni non banali ma anzi oggi più che mai necessarie, visto il mancato accordo fra le nazioni del mondo su come definire il consenso da una parte e su cosa costituisca una molestia e una violenza sessuale dall’altro.
Senza mai sfociare nel morboso o nel sensazionalismo compiaciuto, come tanti registi maschi farebbero alle prese con argomenti simili, Voice potrebbe in alcuni tratti risultare pretenzioso, con quei suoi tempi dilatati apertamente teatrali (soprattutto nella recitazione di Carrousel Maki, di cui colpisce il gesto un po’ affettato di colpirsi il sesso gridando “maledetto cazzo!”), il riflettere ad alta voce dei personaggi principali (e perché intitolarsi Voice altrimenti?) l’alternanza fra bianco e nero e colore o l’esplicito omaggio a certo cinema italiano d’autore (fa un po’ sorridere, in effetti, sentire il gigolò presentarsi come Totò Moretti, così come sembrano forzati i continui richiami a La stanza del figlio nel corso del terzo capitolo), ma tutto è in realtà volutamente costruito come riflessione sul dolore e sugli echi che esso lascia nel corpo e nella mente senza lasciarsi sopraffare dalla sua presenza, dandole un senso per poterne convertire l’energia negativa in nuovo slancio vitale, che doni forza e al contempo non riduca la realtà a un mero trascinarsi nel rancore o nel rimpianto.


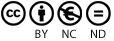





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
