AVVISO: Il seguente articolo contiene spoilers sulla trama di alcuni film del FEFF 26
Una donna di spalle osserva appartamenti bianchi ammassati gli uni sugli altri nello skyline ben riconoscibile di Hong Kong: ecco la locandina dell’edizione FEFF 26, che ci invita esplicitamente ad attraversare la finestra del cinema popolare asiatico per scoprirne (o riscoprirne) l’essenza. Fra i titoli presenti quest’anno figuravano infatti non solo film in concorso e fuori concorso, ma anche documentari, retrospettive, classici restaurati e tributi a registi specifici.
Protagonista di notevole impatto di questa edizione è stato sicuramente Zhang Yimou, a cui l’organizzazione del festival ha consegnato il Gelso d’Oro alla carriera proponendo per l’occasione non solo la versione restaurata di due suoi classici, Lanterne Rosse e Vivere (solo per chi era presente in sala) ma anche una “masterclass” disponibile anche online, durante la quale il regista ha avuto modo di ripercorrere i momenti salienti della sua carriera ed esporre la propria idea di arte. Tra i film in concorso disponibili nella versione online, segnalerei innanzitutto due opere giapponesi: Takano Tofu di Mihara Misuhiro, insignito dell’Audience Award, è forse meno memorabile di altri film premiati negli anni passati dal pubblico del festival; ha però il pregio di descrivere contrasti personali e familiari con garbo e leggerezza, regalandoci anche più di una riflessione non banale sui rapporti umani. Poetico e al contempo aspro è invece Voice di Mishima Yukiko, film a episodi che riflette sull’impatto della violenza sulla vita di alcune persone, per lo più donne, cercando di restituire loro una voce autentica che possa onorare il dolore ma insieme superarlo in gesti catartici di autoaffermazione. Non credo sia un caso che a dirigere e sceneggiare il film sia una donna, visto il modo in cui la violenza viene narrata – senza morbosità nécompromessi, dalla parte di chi l’ha subita e di chi resta, con dignità e intensità.
Altro film scritto e diretto con consapevolezza di genere è Rookie della regista filippina Samantha Lee: a metà fra il coming out e la denuncia contro le molestie ai danni delle giocatrici da parte di fisioterapisti predatori, il film descrive l’innamoramento fra due ragazze come un fatto naturale della vita, senza stigma né enfatizzando eventuali distriminazioni, ma anzi come parte integrante del percorso di consapevolezza delle due protagoniste nel fare i conti con le proprie aspirazioni di sport e di vita.
Meno convincente in tal senso è stato invece The Midsummer’s Voice di Zhang Yudi, unico film da me visto in sala: diretto anche in questo caso da unadonnasupportata da un team tecnico di tutte donne, il film ha sicuramente il pregio didescrivere in toni delicati i primi turbamenti del cuore, dovuti al confronto con l’altro/a e con se stessəalle prese con i cambiamenti fisici della pubertà e in particolare con il cambiamento della voce. Ambientato nel mondo dell’opera di Pechino in una classe di giovani cantanti per lo più maschi(le parti principali femminili sono per tradizione assegnate a cantanti uomini nell’opera di Pechino), il film si incentra tutto sul rischio diperdere la vocee quindi di dover di colpo rinunciare ai propri sogni di gloria e diventare non più la “prima donna” dell’opera ma un guardarobiere qualsiasi. Peccato che il film perda un po’ le proprie potenzialità nella seconda parte, annacquando tutto in una sceneggiatura confusa che sfocia in un trionfo un po’ falso dell’amicizia, che sa più di contentino per la censura che di vera risoluzione drammatica.

Fracassoni e del tutto trascurabili (almeno per quanto mi riguarda) i due blockbuster coreani Alienoid e Alienoid: Return to the Future di Choi Dung-hoon: se i continui sbalzi dal passato al futuro possono risultare divertenti e la recitazione convincente, la trama alla lunga diventa un po’ difficile da seguire, a tratti anche un po’ noiosa, e dopo un po’ si perde il senso di tutto quanto e il perché dovrebbe interessarci sapere quale destino attenda l’eroina e l’eroe principali. Nonostante ciò, i due film risultano godibili se non si pretende coerenza né di trovarci chissà quali significati complessi.
Molto deludenti sia l’unico film thailandese presente in concorso, l’horror Death Whisperer di Taweewat Wantha, piatto sia nella recitazione che nella narrazione, che l’unico film hongkonghese presente online, il poliziesco Rob n Roll di Albert Mak: la presenza di Lam Suet, Lam Ka-tung, Richie Jen ed Aaron Kwok non basta a risollevare il film da una trama inconsistente che vorrebbe forse strizzare l’occhio a PTU di Johnnie To per i continui scatti fra una sottotrama e l’altra, ma alla fine l’unica cosa che la storia solleva è un gran polverone privo di sostanza e girato solo per divertire e poco più. Imbarazzante è risultato invece (Ab)normal desire di Kishi Yoshiyuki: l’intenzione forse era quella di porsi come film atto a celebrare le diversità del desiderio in tutte le sue forme, concentrandosi su persone che si eccitano unicamente stando a contatto con fonti d’acqua senza avere rapporti sessuali con altri esseri umani (pare che proprio in Giappone nel 2024 un uomo sia stato arrestato per aver fatto sesso in un parco pubblico con una fontana). All’atto pratico, però, mescolando in un unico calderone i protagonisti dediti (come dicono loro stessi) a “una perversione dell’acqua”, istanze LGBTQAI+ (?) e pedofilia (che viene solo accennata come possibilità, senza indagarne le cause e le distinzioni rispetto all’argomento principale trattato), il film risulta offensivo per le persone queer, perché la loro identità viene in definitiva equiparata a una perversione, e irresponsabilmente confuso nel voler dare voce a qualcosa di inspiegabile senza indagare a fondo sulla distinzione fra pedofilia (che è un crimine perché coinvolge bambini che non sono consenzienti) e perversione (che presumibilmente riguarda persone adulte e consenzienti). Alla fine, un film del genere non fa altro che alimentare il solito pregiudizio che le persone che sanno poco di Giappone coltivano dentro di sé e che potremmo riassumere con una frase pronunciata da una guida locale a James May nel suo programma Our Man in Japan: “we are a nation of perverts”, siamo una nazione di pervertiti. Come dargli torto, dopo aver visto un film insulso come questo?

Poco coeso nelle sue parti e un po’ superficiale era Tales of Taipei di autori vari intenti a celebrare la capitale taiwanese, anche se solo l’episodio finale parla veramente della città, cercando di darne una lettura originale ma non del tutto riuscita. Più interessante, anche se eticamente discutibile, è Old Fox di Hsiao Ya-chuan, ritratto di un bambino e del suo rapporto conflittuale da un lato con il padre, da lui visto come un debole, e dall’altro con una specie di boss mafioso locale – la vecchia volpe del titolo – nei confronti del quale nutre invece un insieme di ammirazione e spavento (o forse disgusto?). Il film stesso non dà un’interpretazione chiara del personaggio della “volpe”, rimanendo di fatto sospeso in una compiaciuta ambiguitàdi fondo rispetto sia al suo carattere che al suo modus operandi: viene quasi da chiedersi se secondo il regista dovremmo ammirare un criminale e cercare di assomigliare a lui pur di farci strada nella vita. Il messaggio che si insinua fra le righe sembra essere questo, e alla fine il film risulta essere più una celebrazione compiaciutadel sistema capitalista che non una coming-of-age story: la vecchia volpe diventa metonimia del capitalismo, che assolve se stesso senza sconti e senza alcuna ironia, ma è lecito chiedersi perché dovremmo empatizzare con lui o con il protagonista che sembra ammirarlo così tanto, e non invece con il padre “perdente” o con le due donne picchiate senza pietà e senza che nessuno si renda responsabile di tali atti di violenza, quasi a volerligiustificare e normalizzare perché in fondo sono partedel sistema capitalista, che assoggetta (e cannibalizza) chiunque non voglia piegarsi alle sue regole patriarcali esessiste. Quasi una celebrazione del maschio alpha, insomma, che trionfa su tutto e tutti perché è la quintessenza del capitalismo che non mette mai in discussione se stesso.
Dalla sezione Retrospettiva segnalo A rosy life di Kim Hong-joon, se non altro per l’ambientazione particolare della storia in una libreria-fumetteria-rifugio per i disperati e reietti della società sudcoreana del 1987, alle prese con dittatura, proteste studentesche, raid della polizia e censura. Peccato che anche qui ci sia una rappresentazione della violenza (in questo caso dello stupro) totalmente sbagliata, facendola passare per una “normale” fase dell’innamoramento fra un “rude” ma in fondo “romantico” ribelle (e no, è uno stupratore, non un ribelle!!) e una donna indipendente ma disillusa dalla vita che, guarda un po’ tu, in fondo in fondo è innamorata di lui e vuole cercare di dimenticarlo…
Vero e proprio capolavoro di questa edizione del festival è infine Letter to an Angel di Garin Nugroho, opera indonesiana del 1994 presentata in anteprima europea al FEFF 26 in versione restaurata. Anche qui si parla di violenza, ma in maniera del tutto diversa: si tratta infatti di una riflessione sulla violenza di classe e sulla legge del più forte, sull’emarginazione dei bambini e delle donne all’interno di un sistema che non li/e riconosce perché declinato al maschile e gestito da persone adulte che hanno cancellato (o forse non hanno mai conosciuto) l’età dell’infanzia e non ne riconoscono l’utilità e la poesia. Il film ci offre anche un affresco su un mondo rurale di villaggi organizzati in clan e tribù, con tanto di capo villaggio che in realtà conta ben poco, dove il crimine rimane sempre impunito e la Legge, quando decide improvvisamente di apparire, interviene solo per colpire i più deboli proprio perché vanno a minacciare l’ordine violento imposto dai potenti alla realtà. Letter to an angel ci racconta in maniera esemplare un mondo distorto, dove l’innocenza di chi non fa ancora parte del mondo adulto viene codificata come violenza perché la violenza vera è norma, potere, status symbol, e dunque non può e non deve essere messa in discussione.
Ma il cinema serve proprio a questo, sembra suggerisci l’autore: a porre in discussione la realtà e andare oltre il velo della distorsione, per vedere ciò che non c’è (la poesia) ma anche vedere le cose per quel che sono (il potere che corrode e che uccide), e attraversare ancora una volta quella finestra che dai grattacieli di Hong Kong nella locandinadel FEFF 2026 ci invita ad entrare nei mondi del possibile.



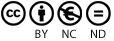





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
