Avvertenza: il seguente articolo contiene spoilers sulla trama del film in oggetto.
Uno dei risultati più notevoli del movimento #Metoo è stato quello di permettere a molte donne sceneggiatrici e registe di poter raccontare delle storie differenti, dove non solo il punto di vista non fosse più quello maschile ma la trama e il quest esistenziale intrapreso dalla protagonista esplorasse concetti e argomenti fino a quel momento ignorati o trascurati dalla cinematografia mainstream. Se questo approccio ha consentito di ribaltare trama e punto di vista in chiave di empowerment in generi quali il dramma sentimentale (si veda ad esempio Ritratto della giovane di fiamme, 2019, scritto e diretto da Céline Sciamma), la commedia amara (Lady Bird, 2019, scritto e diretto da Greta Gerwig) la fantascienza (Little Joe, scritto e diretto da Jessica Hausner), il thriller (Promising young woman, scritto e diretto da Emerald Fennel) o il period drama (Le bal des folles, in parte scritto e interamente diretto da Mélanie Laurent), può risultare ancor più sovversivo in un genere come l’horror (penso al potentissimo Amulet di Romola Garai, vero e proprio grido di vendetta femminista contro un mondo misogino e violento).
Un recente horror dal taglio psicologico in chiave femminista è Clock, film del 2023 scritto e diretto da Alexis Jacknow. La storia parte da uno stereotipo molto radicato in tutte le culture e società umane da cui le donne vengono costantemente influenzate, condizionate e spesso anche soggiogate: trattasi della presunta esistenza di un “orologio biologico” che dovrebbe far scattare il desiderio di diventare madre, perché questo è ciò a cui ognuna di noi aspirerebbe per essere completa e sentirsi “finalmente realizzata”. A partire dal titolo, Clock ribalta questa verità inconfutabile configurandola come qualcosa di mostruoso: presente nell’arco di tutto il film, l’orologio e i simboli ad esso assimilabili – uova, feti, ovuli, ragni, spirali intrauterine, fino al logo dell’infinito scelto dalla clinica per la fertilità, in realtà fatto con due cerchi asimmetrici affiancati l’uno all’altro – costituiscono una minaccia latente che incombe sulla vita sociale e psicologica della protagonista, andando a scardinarne le certezze attraverso una manipolazione costante ed efficiente.
Ella Patel (Dianna Agron) è una designer di successo contesa dagli studi di architettura più in vista della città; felicemente sposata col medico Aidan (Jay Ali) e padrona del proprio tempo libero di cui gode a piene mani fra cibo, coccole, massaggi, sesso e nuotate nella favolosa villa con piscina dove abita, Ella non ha certo nulla da invidiare alle sue amiche etero e lesbiche, tutte immancabilmente madri o incinte. E immancabili sono anche i commenti che le suddette “amiche” riversano su di lei, vera e propria cassa di risonanza di ciò che tante donne subiscono nella vita reale. Prendendo uno condizionamento culturale molto forte come il desiderio di diventare madre, Jamesnow ne rovescia la tesi assolutistica spostando lo sguardo su chi come Ella non si rinosce in una verità data come naturale e inevitabile. Ai numerosi attacchi subiti – “quand’è che tu e Aidan farete figli?”; “la famiglia è tutto”; “non temere, l’orologio comincierà a funzionare anche per te”; “come le passi le giornate senza figli?”; “i figli sono la cosa migliore che possa accaderti nella vita” – Ella può solo opporre la sua personale verità: come dirà alla dottoressa Webber (Nikita Patel) durante una visita di controllo, lei quel famigerato ticchettio non lo sente perché, semplicemente, dentro il suo corpo non c’è nessun orologio.
Ma, trattandosi di un horror dove la condizione della maternità diventa sostanza e materia di (es)pulsioni orrorifiche, la trama porterà Ella a piegarsi al credo della maggioranza: “Tutte le donne hanno un orologio biologico. Forse il suo si è semplicemente rotto” – questo il laconico commento della Dottoressa Webber. Ella ha 37 anni; da un punto di vista legato alla fertilità, si trova in un’eta definibile come “tecnicamente geriatrica”. Nonostante i bellissimi risultati ottenuti sul lavoro, le continue pressioni sociali e psicologiche, non da ultime quelle prevenienti dal padre (Saul Rubinek), che le ricorda come fare figli per una donna ebrea costituisca “un dovere verso gli antenati sopravvissuti ai campi di concentramento”, cominciano ad insinuare in lei l’idea che forse il disagio che prova quando qualcuno le parla di bambini non sia dovuto al sentirsi mancare l’aria e senza via d’uscita, ma forse a quella famigerata sensazione di avere un corpo prossimo alla “scadenza” e che quindi le rimanga pochissimo tempo per diventare “normale” e come tutte le altre donne.
Quando perfino Aidan arriva ad insinuare che la sua assenza di desiderio materno sia una malattia da curare, Ella si arrende, perché capisce che agli occhi di chiunque, anche di quel marito apparentemente così innamorato e in accordo con la sua decisione di non volere figli, in lei c’è qualcosa di sbagliato. L’unica via d’uscita dal cul de sac esistenziale in cui si sente sprofondare ogni giorno di più sembra essere un percorso sperimentale offerto da una clinica biotech, le cui pratiche rivoluzionarie hanno come scopo quello di “riparare” le donne senza orologio biologico o con “ingranaggi inceppati”. Forse, capitolare e accettare ciò che gli altri hanno già deciso al posto suo potrebbe sanare quel senso di inadeguatezza che la assale. Per far questo, Ella decide persino di rinunciare a un progetto di design importantissimo a cui sognava di lavorare da anni. In altre parole, per piegarsi ai condizionamenti culturali che le chiedono di diventare una donna considerata “normale”, Ella deve sacrificare una parte importante di sé, e dunque metaforicamente mutilarsi, per poter incarnare il simulacro perfetto che la cultura dominante garantisce a ogni donna per farla sentire speciale e quasi ammantata di sacralità: diventare madre, veicolo supremo di vita e figura grazie alla quale la riproduzione della specie umana viene garantita.
“Il scopo essenziale di una specie a livello evolutivo è quello di procreare,” dichiara con convinzione la Dottoressa Simmons (Melora Harding), alle cui cure Ella viene affidata. Partendo da tale assunto, il non volere figli non è altro che uno squilibrio chimico, ormonale e mentale, molto simile alla depressione, e come tale curabile attraverso un percorso misto di terapia cognitivo-comportamentale e assunzione di ormoni sintetici al fine di riportare la soggetta cavia al suo stato “naturale” caratterizzato dal desiderio di diventare madre, cancellandone dunque quella che può manifestarsi come tokofobia, o paura del parto. Rientrano nella cura sperimentale anche alcune sessioni psicologiche preliminari, durante le quali Ella ha il compito di concentrarsi sul possibile significato dei simboli ricorrenti nella sua vita: l’orologio a pendola, unico cimelio di famiglia sopravvissuto all’orrore della Shoah; un cumulo di ragni, che rappresenta i corpi degli ebrei sterminati e poi gettati via come insetti; il ritratto lugubre e minaccioso della nonna, vestita di un nero fluttuante e irreale quasi fosse la radiografia di un fantasma.
Nel corso della seduta, Ella arriva a svelare a se stessa e a Simmons il perché mettere al mondo delle persone sia in realtà una scelta egoista e dannosa: lungi dall’essere “il male assoluto” come Simmons dichiara, la Shoah è per lei qualcosa di ascrivibile alla normalità di una società “civilizzata” quale era la Germania del primo ventesimo secolo. Come tale, un evento così atroce potrebbe in realtà riaccadere di nuovo in qualunque parte del mondo, se si creassero quelle stesse condizioni di omertà e tacito assenso che permettono alla violenza di proliferare indisturbata. Procreare in un mondo che coltiva in maniera apparentemente incosciente ma con c(l)inica brutalità i semi della carneficina non porta a nessun giovamento, e chi decide di farlo si rifiuta di capire la natura umana.
Con le sue parole, Ella sembra inconsapevolmente prefigurare quanto le sta per accadere: l’esperienza violenta dell’immersione nella “vasca”, vero e proprio strumento di tortura, arriva a immobilizzarle il corpo, immerso nell’acqua e compresso sotto un coperchio, e al contempo le attacca gli occhi, costantemente oppressi da immagini simboliche volte a stimolare il desiderio di avere figli – fiori che sbocciano, neonati strappati al ventre materno e pulsante, strumenti ginecologici, culminando nell’immagine più evocativa del film, nella quale Ella si trasforma in un immenso orologio a pendolo sanguinante la cui lancetta è un cordone ombelicale che oscilla da una parte all’altra con un neonato appeso alla sua estremità. L’esperienza nella vasca è talmente traumatica ed invasiva da spingere Ella a voler andar via dalla clinica, cosa che le è strettamente vietata perché una volta firmato l’accordo di voler intraprendere la terapia, essa deve essere portata a termine. Conclusi i dieci giorni di percorso, con annessa applicazione di uno speciale impianto intrauterino che rilascerà ormoni nell’organismo per alimentare il desiderio di maternità, Ella può finalmente tornare a casa. Ma la terapia avrà presto degli effetti disastrosi sulla sua percezione della realtà, virata in un bianco e nero allucinatorio dove uova crude, ragni e liquidi simili a placenta occuperanno completamente il campo visivo e i pensieri, con risultati ben poco rispondenti a quel desiderio che così scrupolosamente altri hanno cercato di impiantare dentro di lei con l’inganno come un corpo estraneo, o una protesi che possa sostituirsi alla sua volontà e intenzione.
L’ossessione per la necessità di procreare esposta dalla dottoressa Simmons, e che per Jacknow è la vera mostruosità con cui ogni donna deve purtroppo fare i conti nella vita, sembra fare eco a una delle preoccupazioni maggiori di molti gruppi politici di destra (estrema e non) del mondo contemporaneo: l’estinzione del genere umano, o più propriamente di alcune razze considerate “elette”, anche se il film non si spinge a dirlo esplicitamente. Non vi è infatti alcuna gerarchia fra madri bianche e madri non bianche, ebree o gentili. Anche se il padre di Ella suggerisce che, a causa della Shoah, gli ebrei rimasti in vita siano rimasti in pochi, e procreare assume dunque una valenza di sopravvivenza di un’etnia specifica, Jacknow è più interessata ad esplorare la maternità come destino obbligatorio per tutte le donne e la cultura violenta di coercizione che vi sta alla base, creando così un legame ideale fra due forme di tortura apparentemente lontanissime.
Secondo il pensiero dominante, rappresentato nel film dal mondo “oggettivo” e “imparziale” della Dottoressa Simmons (che in realtà utilizza un metodo fatto di cavie ed esperimenti assimilabile nei principi a quello adottato dai nazisti), la procreazione è sentita come unica scelta possibile nonché obbligata per tutte le donne per garantire un futuro all’umanità, senza però che i fautori di tale teoria (nel film come nella realtà politica della destra contemporanea) prendano mai in considerazione le effettive condizioni economiche, sociali, culturali ed esistenziali con cui la singola donna e la sua futura prole si ritroveranno a dover fare i conti, finendo spesso per non sopravvivere alla crudeltà di un mondo basato solo sulla quantità delle nascite, e non sulla qualità delle vite.
Esistono certo precedenti nella cinematografia horror mainstream (per lo più maschile) che vedevano la maternità come qualcosa di potenzialmente letale per la donna che ospitava una vita nel proprio grembo, ma di solito si trattava di creature “aliene” che giungevano ad “inquinare” la purezza fisica e spirituale o l’integrità eroica della protagonista: si pensi a Rosemary’s Baby di Roman Polanski, dove la gravidanza diventa il marchio del demonio, o ad Alien³ di David Fincher, dove Ripley (oggetto fra l’altro di un possibile stupro di gruppo in quanto unica donna in una base di militari maschi) diventa madre della progenie della propria nemesi, ossia il mostro Alien, che ha ideato l’arma perfetta per distruggerla letteralmente dall’interno, invadendole la carne. In Clock invece, è la maternità in quanto presunta scelta obbligata e inevitabile del percorso di ogni donna a essere scandagliata nel suo potenziale venefico, deleterio e distruttivo per la salute mentale e per l’autodeterminazione della donna.
La maternità, sembra suggerirci Jamesnow, dovrebbe essere una scelta libera e consapevole, non dettata da condizionamenti sociali e culturali, cosa che purtroppo invece avviene ancora oggi a tutte le latitudini, eccettuati forse i paesi scandinavi dove l’efficienza dei servizi che lo stato riserva alle future madri, connesso a uno status politico, sociale e culturale delle donne mediamente più libertario di quello concesso da altri paesi, consentono di decidere in piena consapevolezza se fare figli o meno senza il rischio che tale decisione sia indotta da manipolazioni emotive di qualche tipo.
Confuso nel voler spiegare (e forse anche giustificare) lo status di Ella come donna autrice di se stessa in quanto ebrea che volutamente recide il cordone ombelicale della Shoah e tutto l’orrore che ne è conseguito per “i salvati”, espurgandolo dal proprio corpo e dalla propria mente attraverso la decizione di interrompere la linea famigliare e la crudeltà implicita che ogni creatura umana reca dentro di sé (lei non fa certo eccezione, come ci rivela il colpo di scena finale), il film ha soprattutto il merito di suggerire un percorso femminile (e femminista) autonomo e consapevole rispetto all’equazione donna-madre, esplorando la maternità come potenziale forma di coercizione a cui tutte le donne vengono esposte culturalmente, psicologicamente e socialmente, e la maternità come presunto tratto innato nella donna, ponendone in dubbio lo status di condizione naturale a cui tutte dovremmo aspirare e viceversa ribadendo come, analogamente a tanti altri concetti che si danno per assiomi o verità assolute, il desiderio di maternità scaturisca dalla mente e non solo dal suo corpo. E’ soprattutto la mente, con tutti i suoi condizionamenti e desideri indotti o veri che siano, a determinare quali azioni e decisioni siano importanti da compiere nella vita, o a schiacciare il corpo dentro un costrutto a cui non necessariamente si aspira veramente.
Pochi film mainstream hanno il coraggio di contestare la maternità come destino “naturale” della donna e, anche se in maniera imperfetta (la sagoma della nonna altissima, vera e propria maschera horror abusata che dovrebbe piombare all’improvviso sullo schermo ma che in realtà appare proprio quando te lo aspetti), Clock affronta un argomento tabù come quello di non volere figli, scelta legittima che ogni donna dovrebbe avere. Viste le recenti limitazioni o cancellazioni in toto del diritto all’aborto in diverse parti del mondo, Stati Uniti compresi, questa scelta è più che mai messa in discussione o non affatto contemplata dalle istituzioni, ragion per cui il film di Jamesnow assume anche un valore politico, riaffermando la libertà di scelta di ogni singola donna nel poter dichiarare come Ella senza paura di eventuali ritorsioni: “Sono perfettamente naturale comunque io sia.” Come a dire: “Non cè niente di rotto da riparare in me. Lasciatemi in pace a vivere la mia vita come meglio credo.”
Clock è disponibile sulla piattaforma Disney+


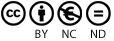





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
